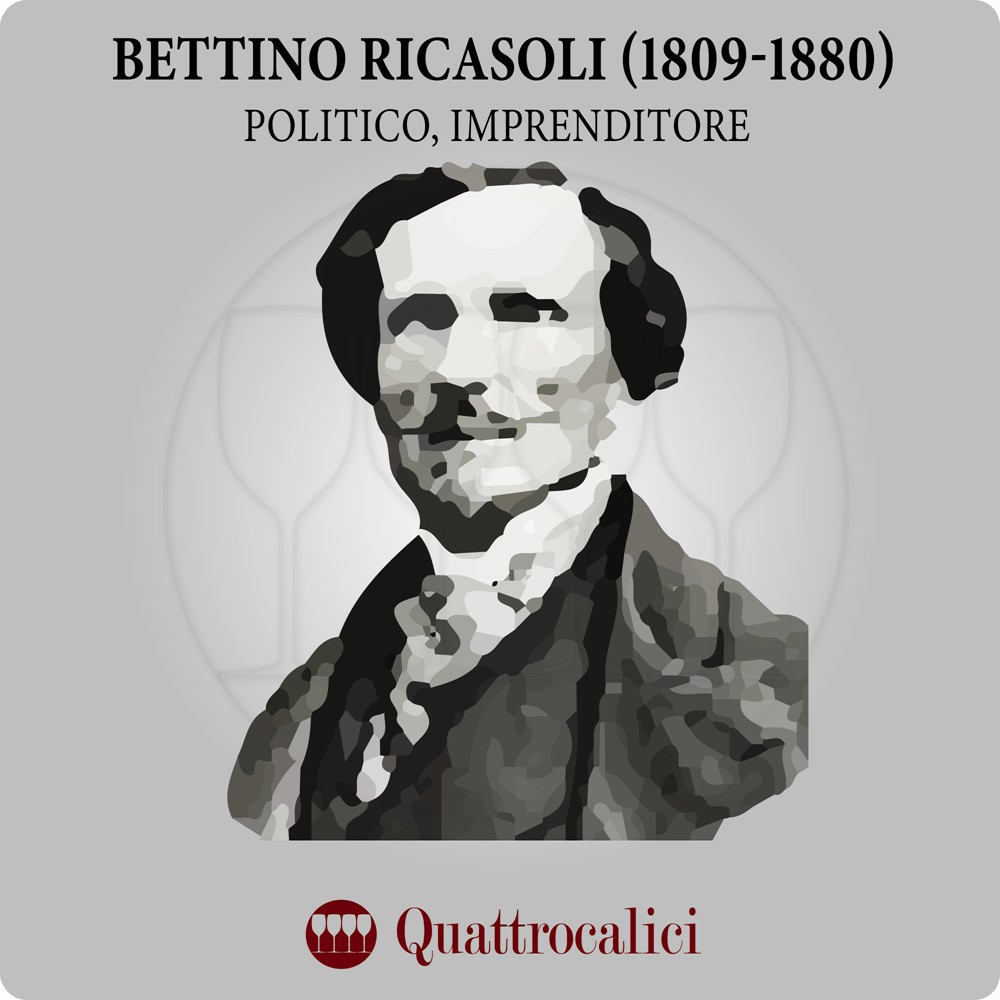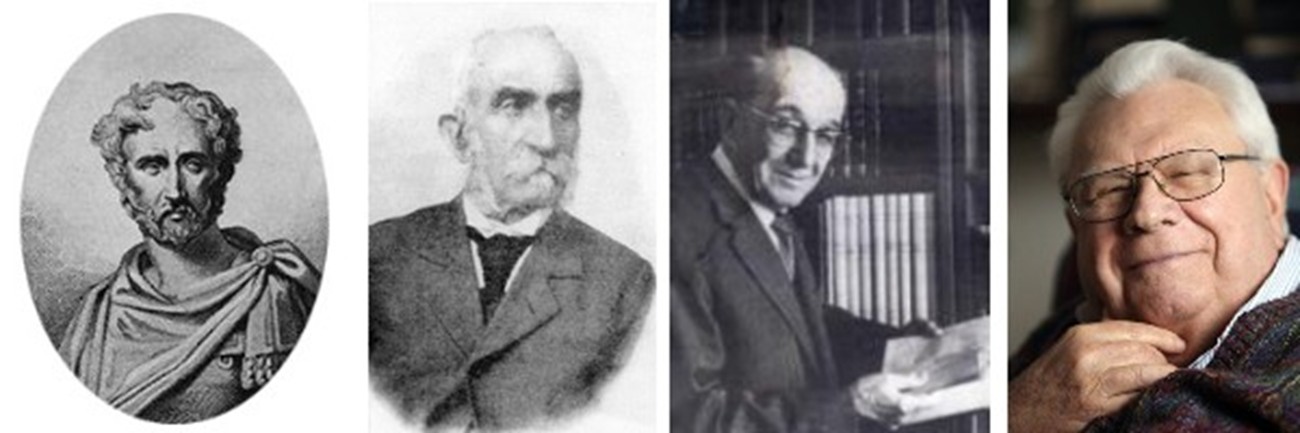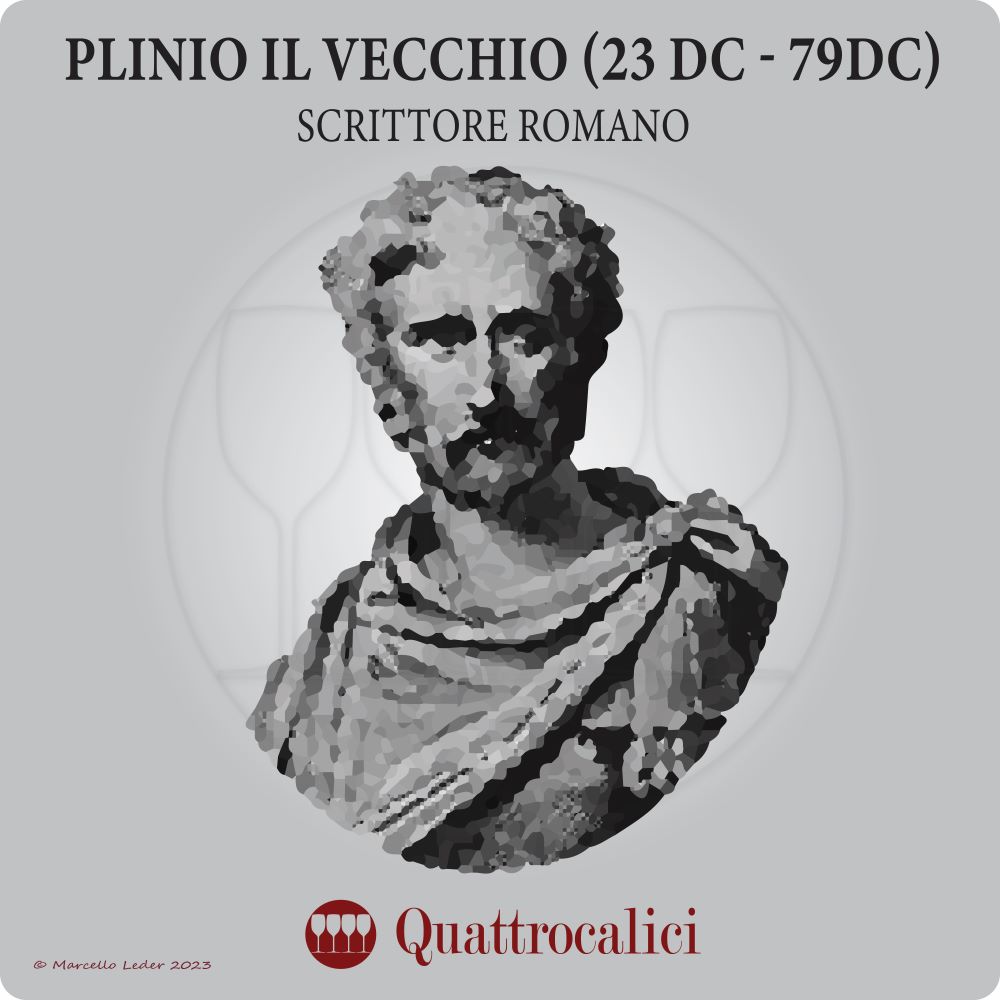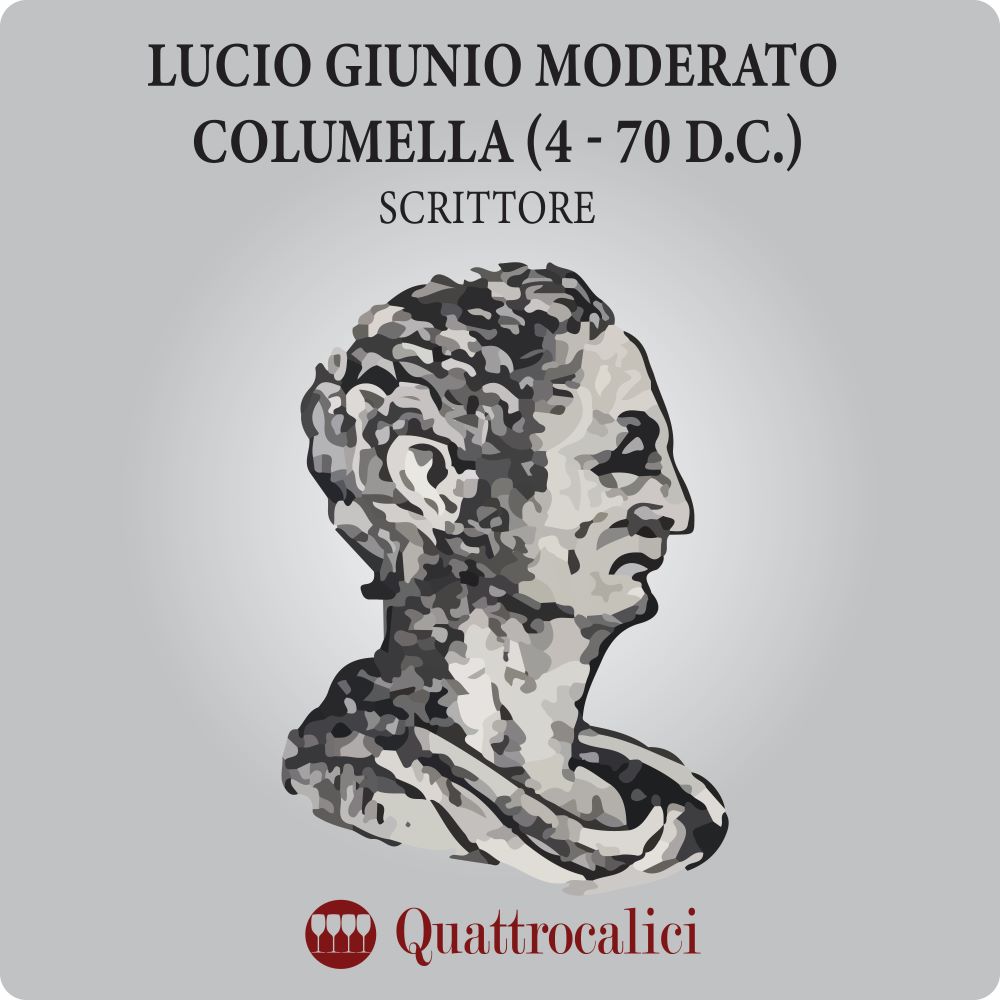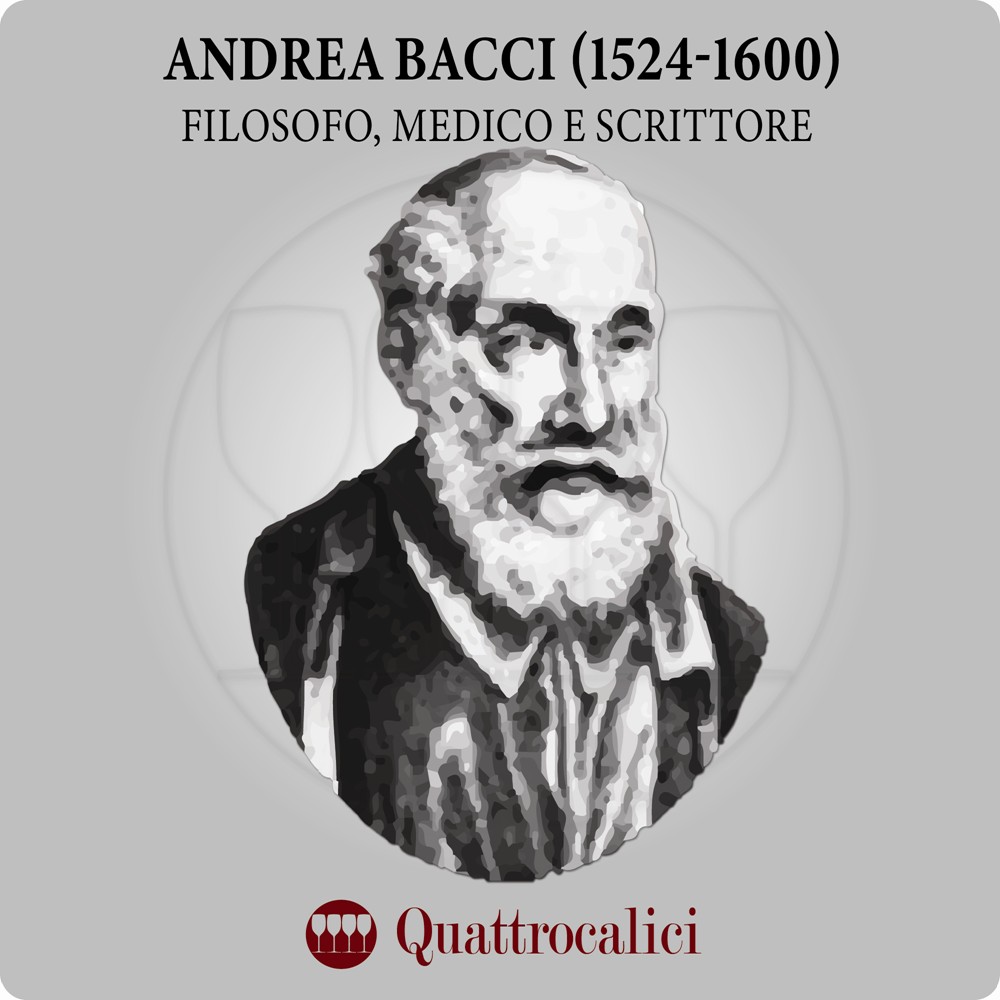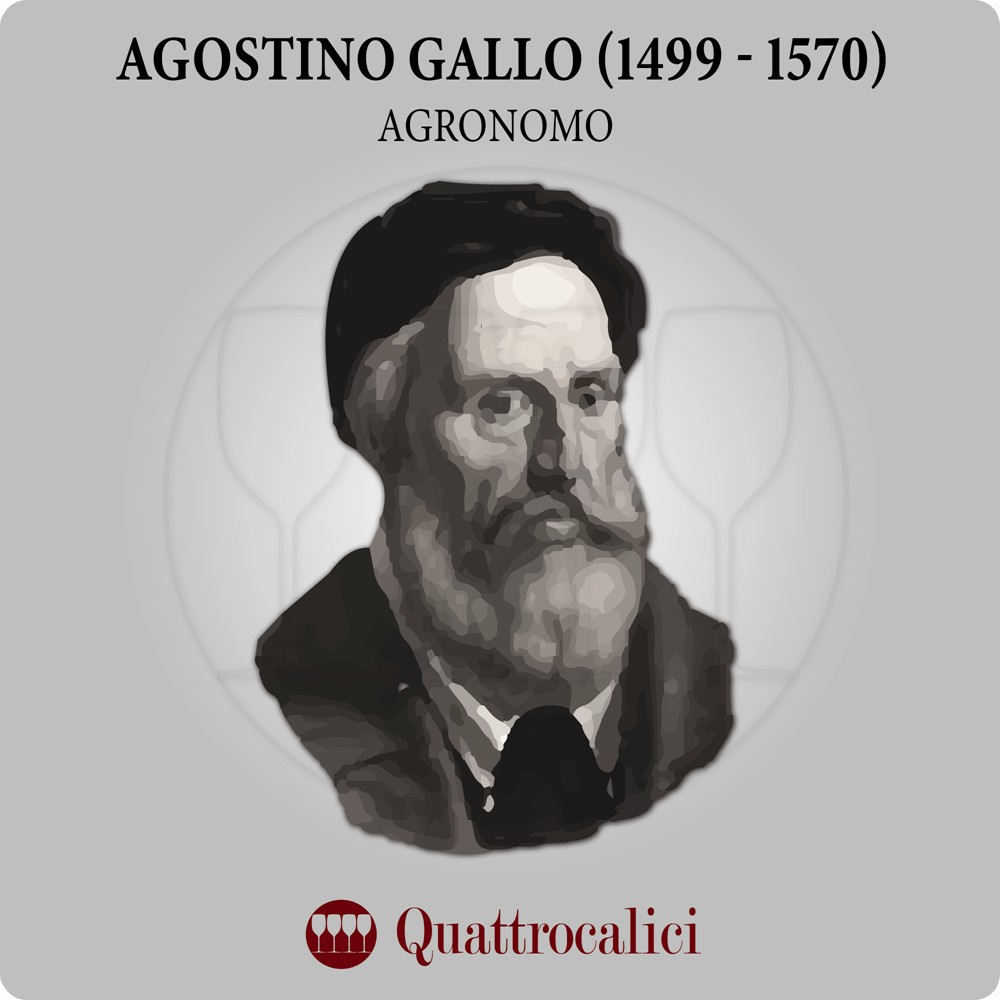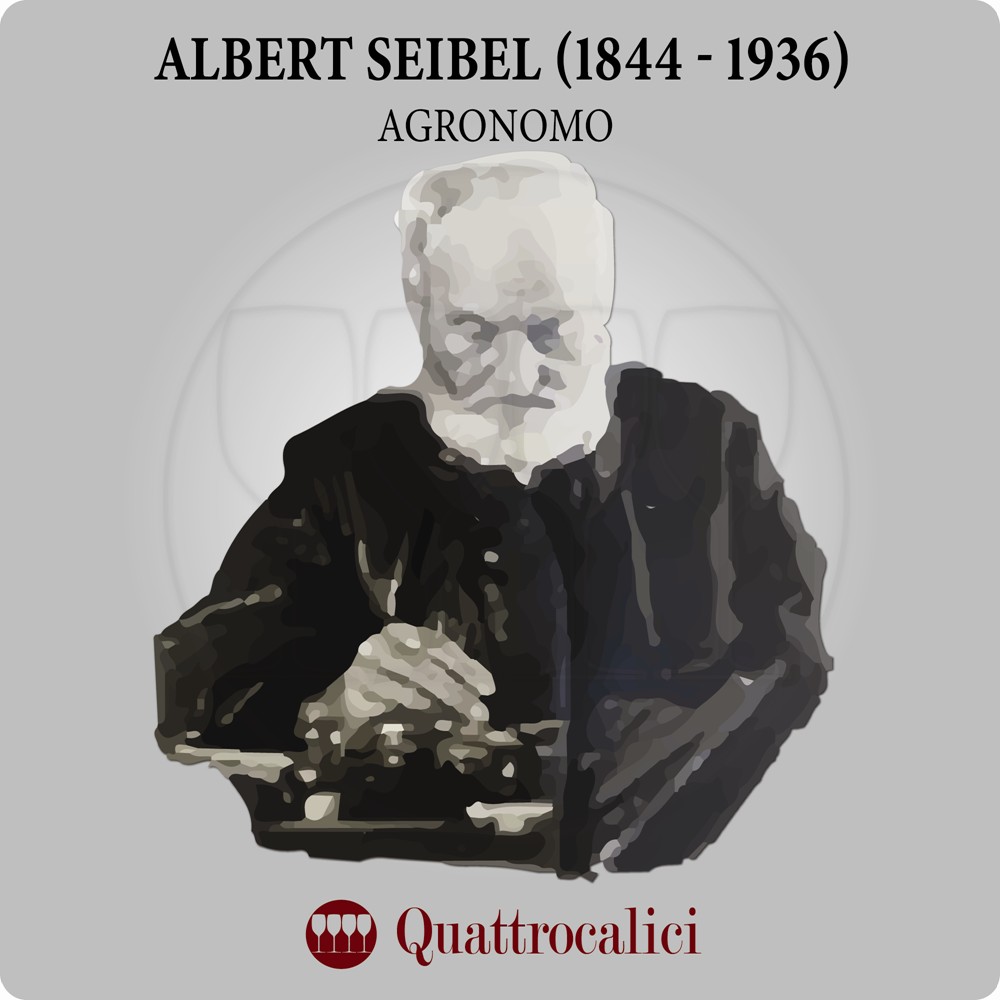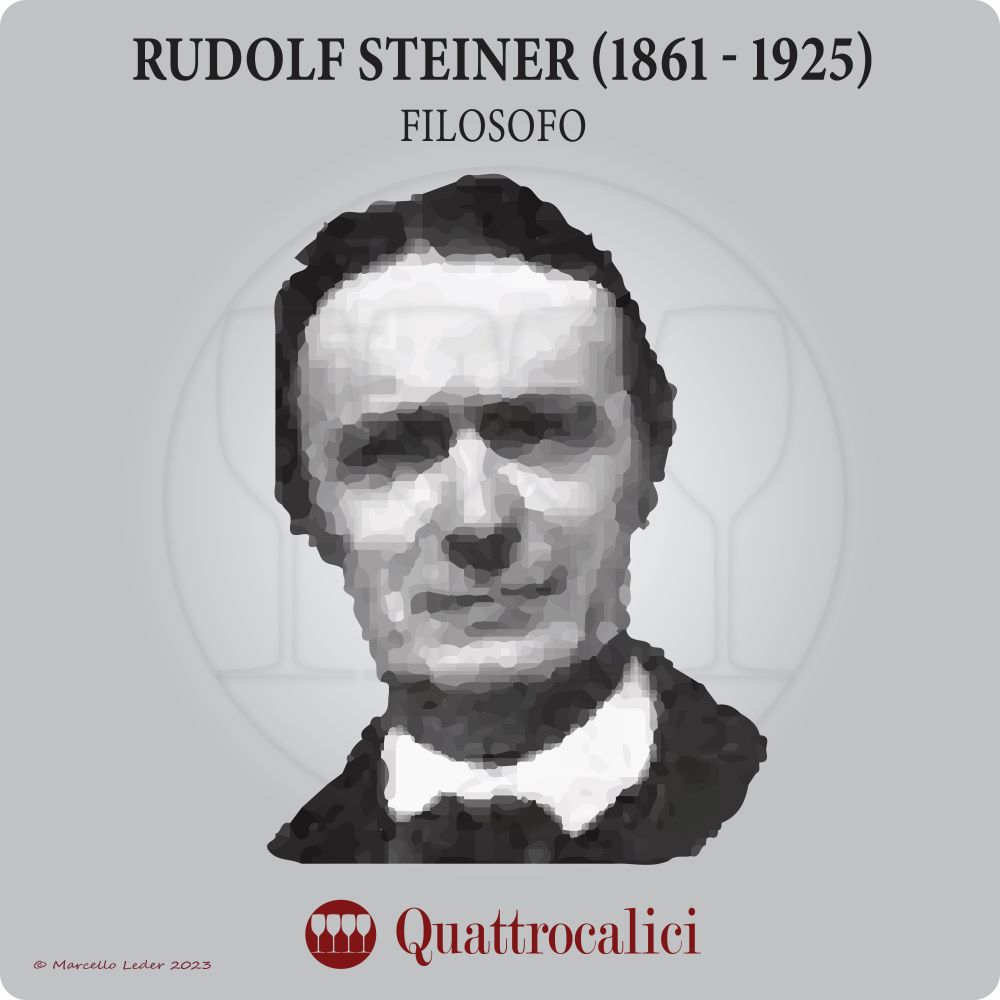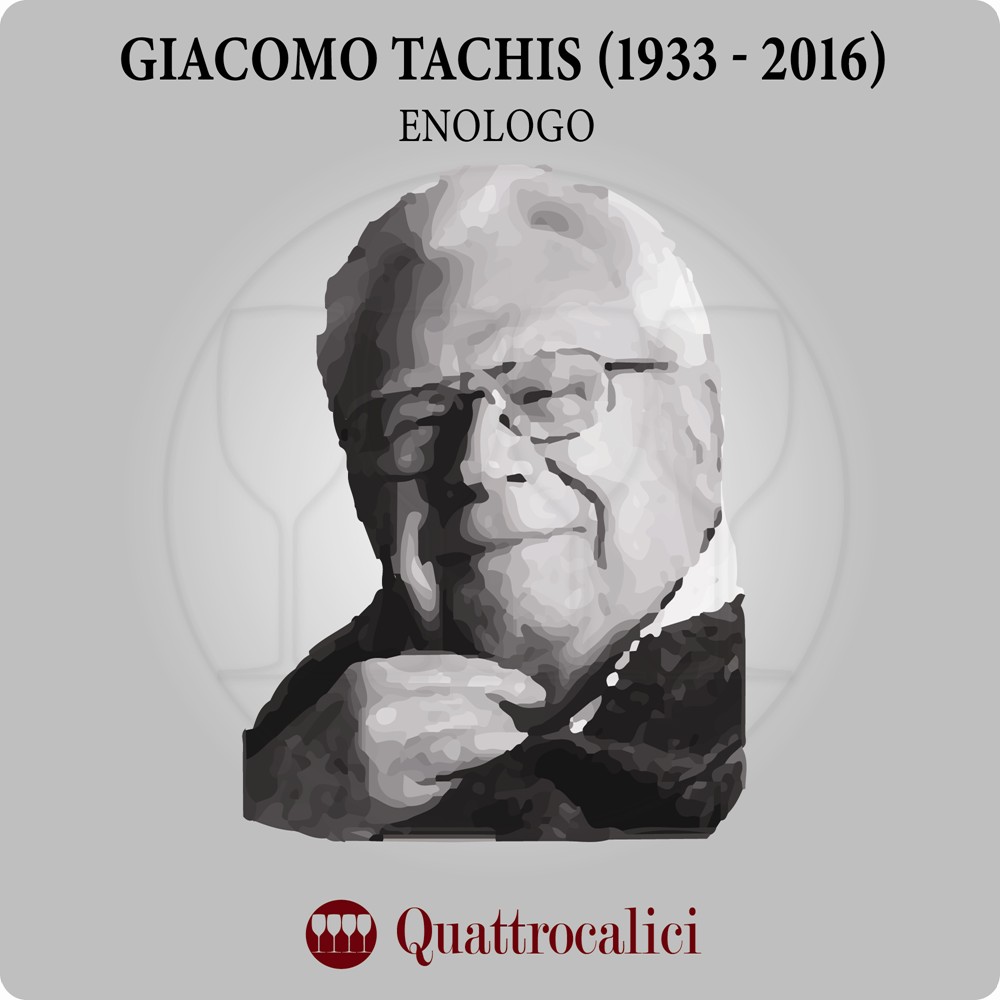Bettino Ricasoli: l’uomo del Chianti e dell’Italia unita
Bettino Ricasoli, nato a Firenze nel 1809 e morto nel 1880 nel suo castello di Brolio, fu una delle figure più emblematiche del Risorgimento italiano, non solo per il suo ruolo politico – succedette a Cavour come Presidente del Consiglio del Regno d’Italia – ma anche per il contributo fondamentale che diede alla viticoltura toscana e alla definizione di quello che, ancora oggi, è il cuore del vino Chianti.
Un aristocratico illuminato tra politica e agricoltura
Discendente di un’antica famiglia nobiliare toscana, i Ricasoli di Brolio, Bettino si trovò a gestire un patrimonio in declino già in giovane età, dopo la morte del padre. La sua formazione autodidatta lo portò a sviluppare un acuto senso pratico, unito a un’intelligenza visionaria che lo rese, negli anni, un personaggio atipico nel panorama italiano: aristocratico, ma profondamente legato alla terra e ai suoi ritmi; conservatore per educazione, ma capace di idee innovative sia in ambito politico che agronomico.
Nel 1834 fondò il Giornale Agrario Toscano, una delle prime pubblicazioni specializzate italiane in ambito agricolo, con l’intento di diffondere tecniche moderne e incentivare la razionalizzazione della produzione. Fu proprio nella gestione della tenuta di Brolio, nel cuore del Chianti, che emerse la sua seconda vocazione: l’imprenditore agricolo con uno sguardo scientifico.
La “ricetta” del Chianti
È nel 1872 che Ricasoli scrive una lettera diventata celebre, indirizzata al professor Cesare Studiati dell’Università di Pisa, in cui illustra quella che oggi viene considerata la prima “ricetta” ufficiale del Chianti. Dopo decenni di sperimentazioni, prove sul campo, selezioni clonali e confronti tra varietà, Ricasoli arriva alla formulazione ideale per lui: 70% Sangiovese, 15% Canaiolo, 15% Malvasia bianca lunga.
La scelta di inserire una quota di uve bianche rispondeva alla volontà di rendere il vino più morbido e pronto al consumo, bilanciando l’austerità e la struttura del Sangiovese. La sua idea era quella di un vino armonico, adatto al clima e al gusto dell’epoca, ma capace di evolversi. È interessante notare come la formula di Ricasoli, sebbene oggi sia stata in parte superata dalle moderne DOCG che consentono Chianti anche in purezza o con varietà internazionali, abbia influenzato per oltre un secolo lo stile del vino toscano più conosciuto al mondo.
Un modello di viticoltura moderna
L’approccio di Ricasoli non fu mai improvvisato. Nella sua tenuta sperimentò metodi di potatura, selezione dei portinnesti, gestione del suolo e uso di fertilizzanti. Fu tra i primi a introdurre il concetto di zonazione empirica, osservando come i diversi suoli di Brolio restituissero vini differenti. Il suo era un metodo scientifico ante litteram, basato sull’osservazione sistematica e sul confronto tra annate e micro-aree.
Il contributo di Ricasoli alla viticoltura moderna va oltre la formula del Chianti: egli rappresenta l’emblema dell’agricoltore-intellettuale che coniuga tradizione e innovazione, capace di vedere nella qualità il vero valore aggiunto del territorio. Fu anche un precursore del concetto di marchio aziendale, facendo del nome “Barone Ricasoli” un’identità forte e riconoscibile, ancora oggi presente sul mercato internazionale del vino.
Il politico e il patriota
Parallelamente alla sua attività agricola, Ricasoli ebbe un ruolo centrale nella storia d’Italia. Monarchico convinto, ma sostenitore del rinnovamento dello Stato, fu uno degli artefici dell’unità nazionale, succedendo a Cavour alla guida del governo nel 1861 e poi nuovamente nel 1866. Fu uomo di rigore e di principio, spesso accusato di intransigenza ma rispettato anche dagli avversari per l’integrità morale.
Il suo patriottismo non era di facciata: rifiutò vantaggi personali, respinse corruzioni, e tentò – con alterne fortune – di ridurre l’influenza clericale nel neonato Stato unitario, portando avanti la linea dell’indipendenza tra potere politico e religioso. La sua visione era quella di un’Italia moderna, fondata su valori etici e civili solidi, e su una classe dirigente preparata e responsabile.
L’eredità di un visionario
Quando morì, nel 1880, Bettino Ricasoli lasciò un’Italia giovane ma già travagliata, e un Chianti destinato a diventare uno dei simboli del made in Italy enologico. Ancora oggi, il castello di Brolio domina le colline del Chianti Classico, memoria tangibile di una visione agricola illuminata e di una passione che ha unito la terra e la patria.
Nel panorama della viticoltura italiana, la figura del “Barone di Ferro” (così lo chiamavano per il suo carattere inflessibile) resta un riferimento imprescindibile: non tanto per l’esattezza della sua “ricetta”, quanto per l’approccio scientifico, l’etica del lavoro e la dedizione alla qualità che continuano a ispirare generazioni di viticoltori. In un’epoca di approssimazioni e di omologazione globale, la lezione di Bettino Ricasoli risuona più attuale che mai: il vino nasce dalla terra, ma si eleva con l’intelletto.