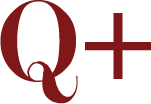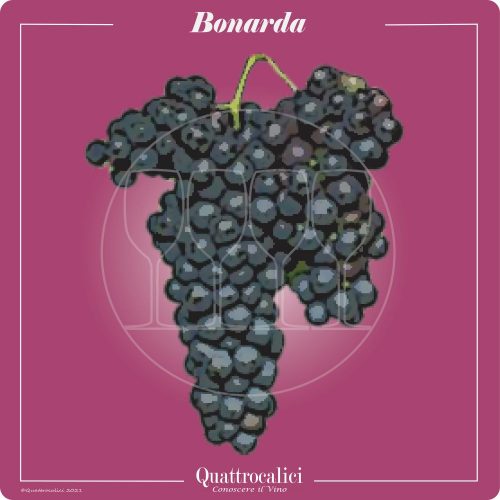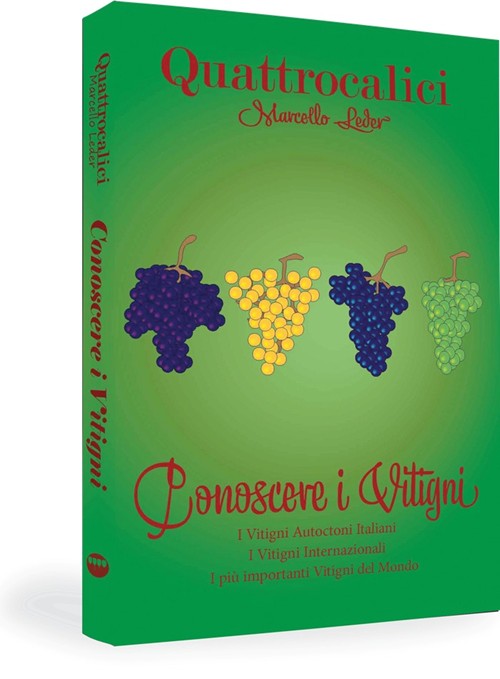Le prime testimonianze scritte risalgono al XVIII secolo, ma la diffusione del nome “Bonarda” potrebbe essere molto più antica. In epoca medievale, vini denominati “bonarde” erano apprezzati per la loro morbidezza e facilità di beva, qualità che ancora oggi caratterizzano le versioni moderne. Nel tempo, il vitigno è diventato un emblema della viticoltura lombarda e piemontese, capace di coniugare tradizione contadina e identità territoriale. La Croatina – che rappresenta la “Bonarda” più nota e coltivata – ha contribuito in modo decisivo alla definizione dello stile dei vini rossi dell’Oltrepò Pavese e delle Colline Piacentine, trovando anche impieghi significativi in Piemonte e nel Nord-Est.
Dal punto di vista storico e culturale, il Bonarda ha incarnato per secoli il vino quotidiano delle campagne padane: un rosso sincero, schietto, spesso frizzante, destinato al consumo locale. Nelle osterie lombarde e piemontesi del Novecento, la “Bonarda” era sinonimo di convivialità, di un vino da tavola allegro ma non banale. Oggi, grazie alla riscoperta dei vitigni autoctoni e alla modernizzazione delle tecniche di vinificazione, il nome Bonarda designa vini di grande qualità, capaci di esprimere eleganza e complessità, pur mantenendo un profilo genuino e territoriale. Il suo carattere poliedrico – capace di generare rossi vivaci, morbidi o longevi – è ciò che ne ha assicurato il successo e la continuità nel tempo.
Zone di coltivazione
La maggiore estensione del Bonarda si trova in Lombardia, nell’Oltrepò Pavese, dove la varietà corrisponde alla Croatina ed è protagonista della denominazione Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC. È ampiamente coltivata anche nelle Colline Piacentine (Emilia-Romagna), dove contribuisce a vini come il Gutturnio DOC insieme al Barbera, e in Piemonte, soprattutto nelle province di Alessandria e Torino, con la Bonarda Piemontese. In misura minore, il vitigno è presente anche nel Veneto e nel Friuli, oltre che in Argentina, dove è giunto probabilmente attraverso l’emigrazione italiana e ha trovato buoni risultati nella provincia di Mendoza.
I terreni ideali per il Bonarda sono collinari, calcareo-argillosi e ben drenati, con esposizioni soleggiate ma ventilate. Il vitigno si adatta bene ai climi temperati e alle forti escursioni termiche tra giorno e notte, che ne favoriscono l’equilibrio acido e l’espressione aromatica. Nelle zone più calde, è in grado di mantenere freschezza e tannini equilibrati, producendo vini di grande equilibrio e versatilità.
Caratteristiche ampelografiche
La pianta di Bonarda (nelle sue varianti principali) presenta vigoria medio-elevata, con portamento eretto e tralci robusti. Le foglie sono di medie dimensioni, pentagonali o trilobate, con margine dentato e lembo di colore verde intenso. Il grappolo è medio o grande, conico o cilindrico, compatto e talvolta alato. Gli acini sono medio-piccoli, sferici, con buccia di medio spessore di colore blu-nero intenso, ricoperta da pruina. La polpa è succosa, di sapore dolce e neutro. Germoglia in epoca media e matura tra fine settembre e inizio ottobre, a seconda della zona. La varietà mostra una buona fertilità e un’elevata resa, che deve essere contenuta per ottenere vini di qualità superiore.
Dal punto di vista fenolico, il Bonarda è ricco di antociani e possiede tannini dolci e maturi, che contribuiscono alla morbidezza e alla piacevolezza dei vini. L’equilibrio tra zuccheri e acidità è generalmente buono, e le uve mantengono freschezza anche in annate calde.
Caratteristiche colturali e agronomiche
Il Bonarda è un vitigno rustico e adattabile, resistente al freddo e alla siccità, ma moderatamente sensibile alla botrite e all’oidio in condizioni di umidità elevata. Predilige terreni collinari ben esposti e ventilati, con moderata fertilità. Le forme di allevamento più diffuse sono il guyot e il cordone speronato, con potature corte per controllare la produttività e migliorare la concentrazione. Le rese ottimali per la qualità si attestano intorno ai 70–80 quintali per ettaro. Il vitigno beneficia di un ciclo vegetativo piuttosto lungo, che gli consente una maturazione fenolica completa e una buona colorazione anche nelle annate fresche. È una varietà versatile, adatta sia a vini giovani e frizzanti sia a versioni più strutturate e longeve, grazie al suo equilibrio naturale tra corpo, acidità e dolcezza dei tannini.
Caratteristiche enologiche del vitigno
Le uve di Bonarda producono mosti di ottima intensità colorante e con acidità equilibrata. I vini che se ne ottengono possono essere vinificati in diversi stili: frizzanti, fermi o leggermente abboccati. La vinificazione tradizionale prevede fermentazione in acciaio inox con macerazioni brevi (per i vini giovani) o più prolungate (per quelli da invecchiamento). In alcune versioni, l’affinamento avviene in botti grandi o in barrique, che arricchiscono il bouquet con note speziate e di vaniglia. L’aroma varietale è fruttato e floreale, con sentori di ciliegia, mora, prugna e violetta. Il Bonarda esprime il meglio delle sue potenzialità quando le rese sono contenute e la maturazione fenolica è completa: in queste condizioni, dà vini pieni, morbidi e di sorprendente longevità, capaci di evolvere verso profumi di liquirizia, cuoio e spezie dolci.
Caratteristiche organolettiche dei vini
I vini da Bonarda si presentano di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei da giovani, tendenti al granato con l’affinamento. Al naso offrono profumi tipici di frutti rossi maturi, ciliegia, mora e lampone, accompagnati da note floreali di violetta e talvolta da leggere sfumature speziate. Al palato risultano morbidi, equilibrati e di medio corpo, con tannini dolci e un’acidità viva che conferisce freschezza e bevibilità. Le versioni frizzanti, tipiche dell’Oltrepò Pavese e delle Colline Piacentine, sono fragranti e vivaci, con un carattere immediato e conviviale; quelle ferme, più complesse, mostrano profondità, struttura e una piacevole vena amarognola nel finale.