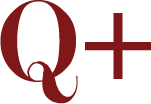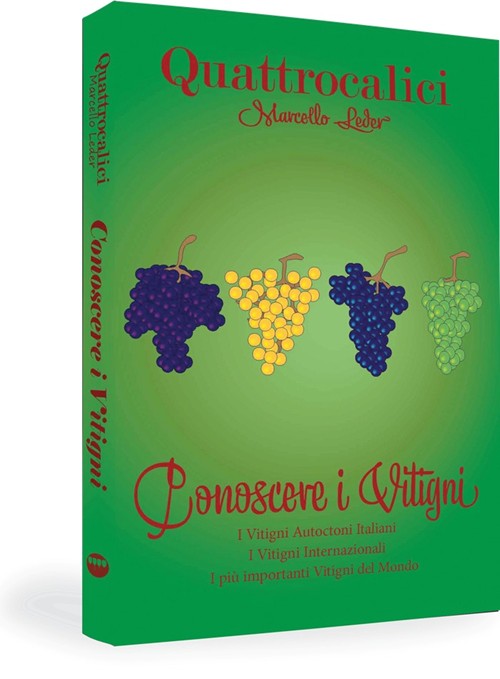È un vitigno che per lungo tempo ha rischiato di scomparire, sopravvivendo in piccoli appezzamenti familiari e in vecchi vigneti promiscui, fino alla recente riscoperta nell’ambito dei programmi di tutela della biodiversità viticola piemontese. Le analisi genetiche ne hanno confermato l’appartenenza al gruppo dei vitigni autoctoni antichi della regione e hanno ipotizzato possibili legami con la famiglia del Nebbiolo, sebbene non di diretta parentela. L’Avarengo rappresenta dunque un raro testimone della viticoltura storica del Piemonte collinare, in cui ogni valle e ogni pendio conservava una varietà propria, adattata nei secoli al microclima e al suolo locale.
Dal punto di vista culturale e territoriale, l’Avarengo è espressione di un Piemonte agricolo autentico e preindustriale, in cui la diversità varietale costituiva una forma di resilienza naturale. Il suo recupero odierno non ha solo un valore enologico, ma anche simbolico: restituire voce ai vitigni minori significa ridare identità a territori che hanno visto la nascita di alcuni dei vini più celebri del mondo. Oggi l’Avarengo è oggetto di studio da parte di centri di ricerca e piccoli produttori che ne stanno esplorando le potenzialità qualitative, rivelando un profilo aromatico sobrio ma elegante e una struttura tannica equilibrata, adatta a vini di medio corpo e grande bevibilità. Il suo carattere rustico e genuino lo rende un interprete fedele della tradizione piemontese, coerente con l’idea di vino territoriale e sostenibile.
Zone di coltivazione
L’areale di coltivazione dell’Avarengo è oggi limitato ad alcune zone del Basso Monferrato e delle Langhe occidentali, in particolare nelle province di Torino, Cuneo e Asti. È segnalato in piccoli vigneti nei comuni di Moncucco Torinese, Cinzano, Pino d’Asti e Cocconato, e in alcune microzone collinari tra il Roero e il Canavese. In passato era coltivato anche nel Biellese e nel Novarese, ma in queste aree è ormai scomparso. L’Avarengo è attualmente iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, e può essere impiegato in alcune denominazioni a livello regionale, come Piemonte DOC e Monferrato DOC, generalmente in assemblaggio. Tuttavia, le vinificazioni in purezza condotte a scopo sperimentale hanno mostrato risultati incoraggianti, suggerendo un potenziale qualitativo interessante soprattutto nei terreni calcarei e marnosi di media collina, esposti a sud e sud-ovest.
Caratteristiche ampelografiche
La pianta di Avarengo è di vigoria medio-bassa, con portamento eretto e sviluppo equilibrato. Le foglie sono di medie dimensioni, orbicolari o trilobate, con margine dentato e pagina superiore verde scuro e leggermente ondulata. Il grappolo è piccolo o medio, di forma cilindrica o conico-cilindrica, piuttosto compatto; gli acini sono piccoli, sferici, con buccia spessa e consistente, di colore blu-nero con abbondante pruina. La polpa è succosa, di sapore neutro ma leggermente amarognolo. L’Avarengo germoglia in epoca media e matura nella seconda metà di settembre. È un vitigno a produttività moderata e costante, caratterizzato da un’ottima sanità delle uve e da una buona tolleranza alle principali malattie crittogamiche. Il suo corredo fenolico equilibrato e l’elevata concentrazione di antociani conferiscono ai vini un colore intenso e stabile.
Caratteristiche colturali e agronomiche
L’Avarengo si adatta bene ai suoli calcareo-marnosi e argillosi tipici delle colline piemontesi, preferendo le esposizioni ben ventilate e le altitudini comprese tra 200 e 400 metri. È un vitigno rustico, resistente alla siccità e alle variazioni termiche, con buona capacità di adattamento ai climi collinari freschi. È moderatamente sensibile all’oidio, ma mostra discreta resistenza alla botrite grazie alla buccia spessa e alla compattezza del grappolo. Le forme di allevamento più indicate sono il guyot e il cordone speronato, con potature medio-corte per contenere la vigoria e favorire una buona maturazione fenolica. Le rese ideali per la qualità si attestano sui 70–80 quintali per ettaro. In condizioni ottimali, l’Avarengo produce uve di ottimo equilibrio zuccheri/acidi, adatte sia a vini giovani e fragranti sia a versioni più strutturate con breve affinamento in legno.
Caratteristiche enologiche del vitigno
Le uve di Avarengo offrono mosti di colore intenso e profilo aromatico sobrio ma fine. La vinificazione avviene tradizionalmente in acciaio inox con macerazioni di media durata (8–10 giorni), per preservare il frutto e limitare l’estrazione tannica. Il vino risultante è di medio corpo, con acidità equilibrata e tannino setoso. Alcuni produttori sperimentano brevi affinamenti in botti grandi o in barrique usate, che arricchiscono la complessità senza sovrastare l’espressione varietale. L’Avarengo si presta bene anche a vinificazioni leggere, quasi in stile “vino d’annata”, ma mantiene una struttura solida che gli consente di evolvere positivamente per alcuni anni. L’aromaticità è dominata da note di ciliegia, prugna e viola, con accenni minerali e speziati, mentre il corredo polifenolico assicura una buona stabilità cromatica nel tempo.
Caratteristiche organolettiche dei vini
I vini da Avarengo si presentano di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso esprimono profumi delicati di frutti rossi maturi — ciliegia, lampone, mora — accompagnati da note floreali e lievi toni di spezie dolci. Al palato sono armonici, freschi e di medio corpo, con tannini fini e ben integrati, e una sensazione complessiva di equilibrio e scorrevolezza. La acidità vivace conferisce slancio e bevibilità, mentre il finale è asciutto e persistente, con piacevoli sfumature amarognole. L’Avarengo dà vini che riflettono la sobrietà e la compostezza tipiche del Piemonte, ideali da bere giovani ma capaci di evolvere con grazia per 3–5 anni. È un vino che si abbina perfettamente a piatti della tradizione regionale — salumi, paste ripiene, carni bianche e formaggi semistagionati — e che, nella sua riscoperta contemporanea, rappresenta un frammento prezioso della memoria viticola piemontese.