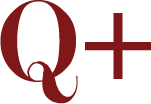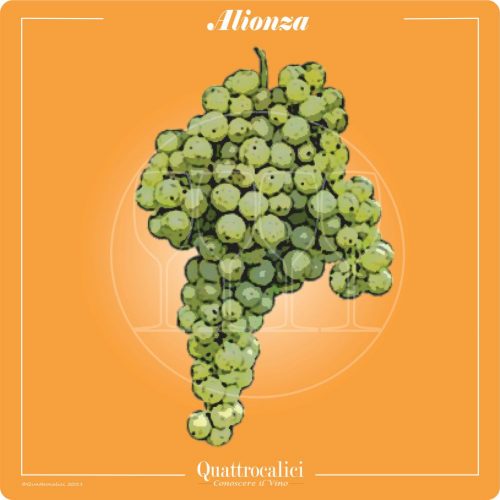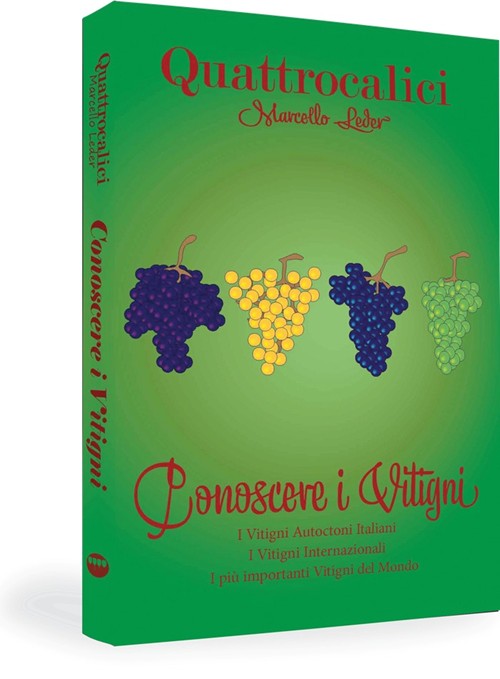La sua importanza storica va oltre l’aspetto produttivo: l’Alionza è parte del patrimonio genetico e culturale della viticoltura emiliana, testimonianza di un’epoca in cui la biodiversità era alla base della resilienza dei vigneti. In tempi recenti, istituti agrari e consorzi locali hanno avviato studi genetici e microvinificazioni per comprenderne meglio le potenzialità, scoprendo una varietà dotata di interessante equilibrio acido e buona aromaticità, ideale per vini bianchi freschi o basi spumante. Questo rinnovato interesse si inserisce in un movimento più ampio volto a recuperare le identità varietali locali e a restituire espressione territoriale ai vini dell’Emilia, accanto ai più noti Lambruschi e Pignoletti. L’Alionza rappresenta quindi una risorsa preziosa per una viticoltura sostenibile e diversificata, capace di unire tradizione e modernità.
Zone di coltivazione
La coltivazione dell’Alionza è oggi limitata ma in ripresa. Il suo epicentro si trova nella provincia di Bologna, in particolare nei comuni collinari tra Monteveglio, Savigno e Castello di Serravalle, ma piccole superfici sono presenti anche nelle aree di Modena e Reggio Emilia. In passato era diffusa in tutta la pianura emiliana, dove veniva impiegata nei vini da tavola locali. Oggi alcune aziende e istituti sperimentali ne curano la vinificazione in purezza, ottenendo risultati incoraggianti, soprattutto nelle zone collinari con terreni calcareo-argillosi e buone escursioni termiche. L’Alionza è iscritta al Registro Nazionale delle Varietà di Vite e può essere utilizzata in alcune denominazioni regionali, tra cui la Colli Bolognesi DOC, anche se la maggior parte delle produzioni attuali rientra in vini a Indicazione Geografica o in progetti di recupero varietale. All’estero non è conosciuta né coltivata.
Caratteristiche ampelografiche
La pianta di Alionza è di vigoria medio-alta, con portamento semieretto e tralci lunghi e flessibili. Le foglie sono di medie dimensioni, orbicolari o trilobate, con lembo verde chiaro e superficie leggermente ondulata. Il grappolo è medio o grande, conico-piramidale, spesso alato e di media compattezza; gli acini sono medio-grandi, sferici, con buccia sottile e pruinosa di colore giallo-verde, tendente al dorato con la maturazione. Il vitigno germoglia precocemente e matura tra fine settembre e inizio ottobre. È caratterizzato da buona fertilità delle gemme e regolarità produttiva, con rese naturali piuttosto elevate. L’Alionza presenta un contenuto zuccherino moderato e un’acidità relativamente alta, caratteristiche che ne fanno una base interessante per vini freschi e equilibrati. Non possiede una spiccata aromaticità varietale, ma piuttosto una finezza neutra che valorizza le note minerali e floreali dei suoli d’origine.
Caratteristiche colturali e agronomiche
L’Alionza si adatta bene ai suoli calcarei, limosi o argillosi dell’Emilia, mostrando una buona resistenza alla siccità e alle variazioni termiche stagionali. È una varietà rustica e affidabile, poco esigente, capace di mantenere costanza produttiva anche in annate difficili. Tuttavia, la sua elevata produttività richiede potature attente e selezioni di grappoli per evitare eccessive diluizioni. Le forme di allevamento più diffuse sono il guyot e il cordone speronato, che garantiscono equilibrio vegeto-produttivo e buona esposizione dei grappoli. Il vitigno è moderatamente sensibile all’oidio e alla botrite in annate piovose, ma mostra discreta resistenza alla peronospora. Le rese ideali per la qualità si aggirano sui 90 quintali per ettaro. In condizioni favorevoli, l’Alionza può fornire mosti di elevata freschezza e buona struttura acida, adatti sia alla vinificazione diretta sia alla produzione di basi per spumanti metodo Charmat.
Caratteristiche enologiche del vitigno
Le uve di Alionza offrono mosti di colore giallo paglierino chiaro, con profumi delicati di fiori bianchi, erbe e frutta fresca. La vinificazione avviene generalmente in acciaio inox a temperatura controllata, per preservare la componente aromatica e l’acidità naturale. In purezza dà vini secchi, equilibrati e vivaci, mentre in assemblaggio apporta freschezza e bevibilità. La sua neutralità aromatica consente anche un impiego enologico versatile: può essere utilizzata per vini fermi, frizzanti o leggermente spumantizzati. Nelle versioni a presa di spuma si distingue per finezza e stabilità della bollicina, grazie alla buona dotazione acida. L’Alionza si presta inoltre all’affinamento sur lies, che ne aumenta la struttura e la complessità. Pur non essendo un vitigno aromatico, può sviluppare con l’età note di miele, mandorla e frutta secca, mantenendo un profilo elegante e coerente con i vini bianchi emiliani di collina.
Caratteristiche organolettiche dei vini
I vini da Alionza si presentano di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, limpidi e brillanti. Al naso offrono profumi fini e discreti di fiori di campo, mela verde, pera e agrumi, accompagnati da leggere sfumature minerali. Al palato sono freschi, armonici e di corpo medio, con acidità equilibrata e finale secco e pulito. Le versioni frizzanti esprimono fragranza e immediatezza, mentre quelle ferme mostrano una struttura più ampia e una piacevole sensazione sapida. L’Alionza dà vini di pronta beva ma capaci di evolvere positivamente per alcuni anni, mantenendo tensione e precisione gustativa. Si abbina con facilità ai piatti della tradizione emiliana, dai salumi alle paste ripiene, ai piatti di pesce d’acqua dolce e di verdure. Nella sua semplicità autentica, rappresenta un tassello prezioso della rinascita dei vitigni autoctoni dell’Emilia e un raro esempio di equilibrio tra rusticità e finezza territoriale.