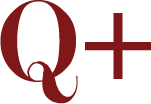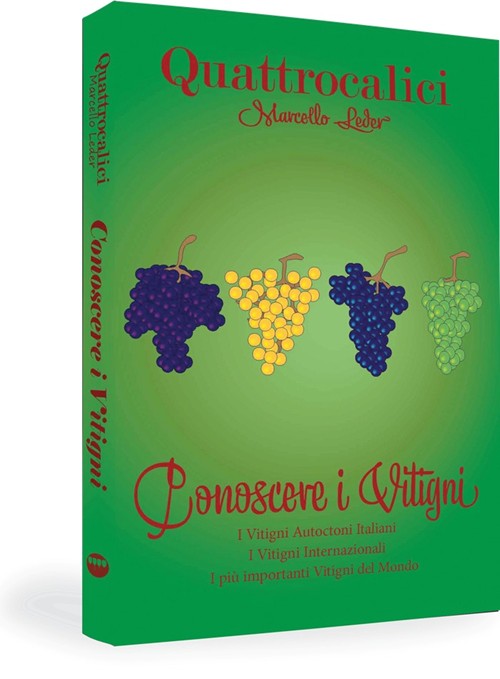Documentazioni storiche risalenti al XIX secolo ne attestano la coltivazione sporadica nel territorio aquilano e nel reatino, dove veniva utilizzato in uvaggio con altre varietà locali per produrre vini rustici, colorati e di medio corpo. La progressiva diffusione di varietà più produttive e regolari — come il Montepulciano e il Sangiovese — ne ha quasi determinato la scomparsa, sopravvivendo solo in pochi appezzamenti di vecchie vigne, oggi oggetto di recupero genetico e di studio da parte di istituti agrari regionali.
La riscoperta del Cavrara si inserisce nel più ampio movimento di tutela dei vitigni autoctoni minori italiani, volto a salvaguardare la biodiversità ampelografica e a valorizzare il patrimonio enologico delle zone interne appenniniche.
Dal punto di vista storico e culturale, il Cavrara rappresenta un frammento della viticoltura tradizionale di montagna, fatta di piccole vigne familiari e di vitigni selezionati per resistere alle difficili condizioni climatiche. Simbolo di un’agricoltura resiliente e povera, oggi è oggetto di interesse per la possibilità di restituire vini identitari e di forte carattere territoriale, in linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità e l’autenticità varietale.
Zone di coltivazione
Il Cavrara è oggi presente in pochissime aree vitate dell’Abruzzo, in particolare nelle province dell’Aquila e di Pescara, e marginalmente nel Lazio orientale, nelle zone collinari del Reatino. I pochi esemplari noti provengono da vigne antiche, spesso promiscue e non specializzate, situate tra i 300 e i 600 metri di altitudine, su terreni calcarei, ghiaiosi e poveri di sostanza organica.
Le condizioni climatiche di queste aree — caratterizzate da estati calde ma ventilate e da notevoli escursioni termiche notturne — favoriscono una maturazione lenta e completa delle uve, con buona conservazione dell’acidità e sviluppo di aromi fini. Al di fuori delle regioni d’origine, il vitigno non risulta coltivato, se non in ambito sperimentale o in collezioni ampelografiche pubbliche.
Caratteristiche ampelografiche
La pianta di Cavrara è di vigoria medio-elevata, con portamento semieretto e buona fertilità. Le foglie sono di medie dimensioni, pentagonali o trilobate, con margine dentato e lembo verde scuro. Il grappolo è medio, conico o cilindrico, piuttosto compatto e a volte alato. Gli acini sono medio-piccoli, sferici, con buccia spessa e consistente di colore blu-nero, ricca di antociani e tannini. La polpa è succosa, di sapore neutro e lievemente amarognolo.
Il vitigno germoglia in epoca media e matura tardi, tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre. La resa è medio-bassa e fortemente dipendente dalle condizioni pedoclimatiche e dalla potatura, ma la qualità delle uve è elevata, con un buon equilibrio tra zuccheri e acidità. È una varietà adatta a climi freschi e altitudini elevate, dove la lentezza di maturazione ne valorizza le caratteristiche aromatiche e strutturali.
Caratteristiche colturali e agronomiche
Il Cavrara predilige terreni calcarei o argillosi, asciutti e ben drenati, tipici delle zone collinari e pedemontane abruzzesi. È un vitigno rustico, adattabile, resistente alla siccità e alle basse temperature, ma sensibile alla botrite in annate piovose e durante la fase di maturazione. Le forme di allevamento più adatte sono il guyot e il cordone speronato, con potature medie che consentono un buon equilibrio vegeto-produttivo.
Nelle vigne tradizionali, il Cavrara era spesso coltivato ad alberello o a tendone basso, in consociazione con altre varietà locali. La sua produttività limitata e la struttura equilibrata dei mosti lo rendono oggi interessante per microvinificazioni di qualità, destinate a esprimere la tipicità dei territori interni dell’Appennino centrale.
Caratteristiche enologiche del vitigno
Le uve di Cavrara danno mosti di colore rubino intenso, con buona concentrazione di polifenoli e acidità vivace. La vinificazione avviene generalmente in acciaio inox con macerazioni di media durata, volte a preservare il profilo fruttato e la freschezza varietale. Eventuali affinamenti in legno piccolo o grande esaltano la componente speziata e balsamica.
L’aromaticità è dominata da note di frutti rossi (amarena, ciliegia, ribes) e neri (mora, prugna), con accenni floreali di violetta e leggere sfumature di erbe aromatiche e grafite. Il vino mostra buona struttura, equilibrio tra morbidezza e tannicità, e una piacevole freschezza che ne sostiene la bevibilità. È un vitigno di interessante potenziale qualitativo, capace di unire rusticità e eleganza.
Caratteristiche organolettiche dei vini
I vini da Cavrara si presentano di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso offrono profumi netti e puliti di ciliegia, mora e prugna, accompagnati da note floreali di violetta e leggere sfumature balsamiche e minerali. Con l’affinamento emergono toni di spezie dolci, tabacco e sottobosco. Al palato sono equilibrati, di corpo medio-pieno, con tannini morbidi ma ben presenti, acidità viva e finale lungo e armonioso. Le versioni giovani privilegiano la freschezza e la fragranza fruttata, mentre le versioni affinate in legno mostrano maggiore complessità e profondità.