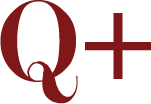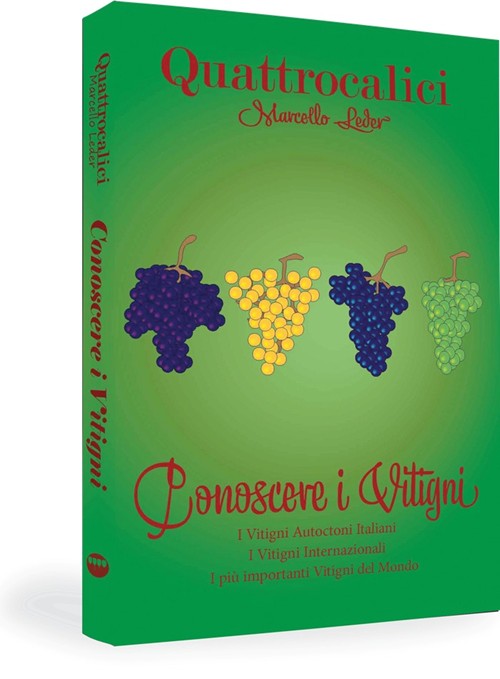Nel corso del Novecento, con la progressiva razionalizzazione degli impianti e la selezione a favore della Corvina e delle altre varietà “principali”, la superficie coltivata a Corbina si è ridotta drasticamente, fino a farne oggi un vitigno raro, conservato soprattutto in vecchi vigneti misti o in impianti sperimentali. La sua presenza nei disciplinari è marginale o assorbita nelle categorie generiche di vitigni “minori storici”, ma il suo ruolo storico negli uvaggi veronesi rimane un tassello importante della biodiversità viticola locale.
Dal punto di vista culturale, la Corbina è una delle tante uve “di campagna” che hanno costituito, in passato, la base ampelografica dei vini quotidiani delle colline venete. La sua parziale scomparsa riflette il passaggio da una viticoltura promiscua e policlonale a una viticoltura moderna, più semplificata, ma il rinnovato interesse per i vitigni autoctoni minori ne sta riportando il nome all’attenzione di studiosi e appassionati.
Zone di coltivazione
La Corbina è storicamente legata al territorio della Valpolicella e alle aree collinari della provincia di Verona, in particolare nei comuni della Valpolicella classica e nelle zone limitrofe (Negrar, Fumane, Marano, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, ma anche nella fascia collinare verso la Val d’Illasi e la Val di Mezzane). Era coltivata spesso in promiscuità con altri vitigni locali, in vigneti misti destinati alla produzione di vini da consumo familiare o da taglio.
Oggi la Corbina è presente su superfici molto limitate, spesso in vecchi impianti, con un ruolo marginale all’interno degli uvaggi per i vini veronesi. In alcuni casi è mantenuta come componente accessoria nei blend per Valpolicella e Veronese IGT, ma non costituisce più una varietà di riferimento. Al di fuori del Veneto non ha una diffusione significativa e rimane un vitigno essenzialmente locale.
Caratteristiche ampelografiche
La pianta di Corbina presenta vigoria medio-elevata, con portamento semieretto e tralci piuttosto robusti. Le foglie sono di dimensioni medio-grandi, pentagonali, trilobate o pentalobate, con lembo verde intenso e superficie leggermente bollosa. Il grappolo è di grandezza medio-grande, conico o cilindrico-conico, spesso alato, di compattezza da media a elevata. Gli acini sono medio-grandi, sferici, con buccia spessa e pruinosa di colore blu-nero, ricca di antociani, ma generalmente meno concentrata rispetto alla Corvina. La polpa è succosa, di sapore tendenzialmente neutro, con buona dotazione zuccherina e acidità moderata.
Germoglia in epoca media e matura piuttosto tardi, in linea con le altre varietà veronesi. La produttività è buona e abbastanza costante, caratteristica che ne ha favorito storicamente l’utilizzo nei vigneti contadini per assicurare resa e volume di vino.
Caratteristiche colturali e agronomiche
La Corbina si adatta bene ai terreni collinari calcareo-argillosi e alle esposizioni soleggiate tipiche delle vallate veronesi. È un vitigno rustico, che sopporta discretamente la siccità e le condizioni di moderato stress idrico, e si è dimostrato ben adattato ai sistemi di allevamento tradizionali della zona, come la pergola veronese e, in impianti più moderni, il guyot.
La varietà mostra una buona resistenza alle principali malattie crittogamiche, pur potendo essere sensibile alla botrite nelle annate particolarmente piovose, specie per la compattezza dei grappoli. Le rese, se non contenute, tendono a essere elevate, con conseguente diluizione della componente aromatica e fenolica; per questo, nelle rare esperienze qualitative recenti, si adottano carichi produttivi più moderati e una gestione accurata della chioma per migliorare l’esposizione dei grappoli e la maturazione fenolica.
Caratteristiche enologiche del vitigno
Le uve di Corbina danno mosti di colore rosso rubino di buona intensità, con contenuto in antociani adeguato ma non estremo e acidità mediamente contenuta. Dal punto di vista enologico, il vitigno è stato tradizionalmente impiegato come componente di uvaggi per i vini veronesi, più che vinificato in purezza. Apporta morbidezza, rotondità e un contributo cromatico utile, senza però imprimere al vino un carattere aromatico particolarmente marcato.
La vinificazione avviene generalmente in acciaio inox, con macerazioni di durata media, spesso in cofermentazione con Corvina, Rondinella e altre varietà locali. In passato le uve venivano talvolta sottoposte a un breve appassimento insieme alle altre, contribuendo alla produzione di vini più ricchi e morbidi, ma il suo ruolo, rispetto a Corvina e Rondinella, era comunque secondario.
Caratteristiche organolettiche dei vini
I vini ottenuti da Corbina, soprattutto in uvaggio, si presentano di colore rosso rubino con riflessi violacei da giovani. Il profilo aromatico è sobrio, con note di frutta rossa semplice (ciliegia, prugna) e leggere sfumature floreali ed erbacee. Al palato i vini risultano di corpo medio, con tannini piuttosto morbidi e acidità moderata, più orientati alla bevibilità che alla struttura. In assemblaggio con vitigni più caratterizzati, la Corbina contribuisce a dare volume e una certa rotondità senza sovrastare il profilo varietale dominante (in particolare quello della Corvina).